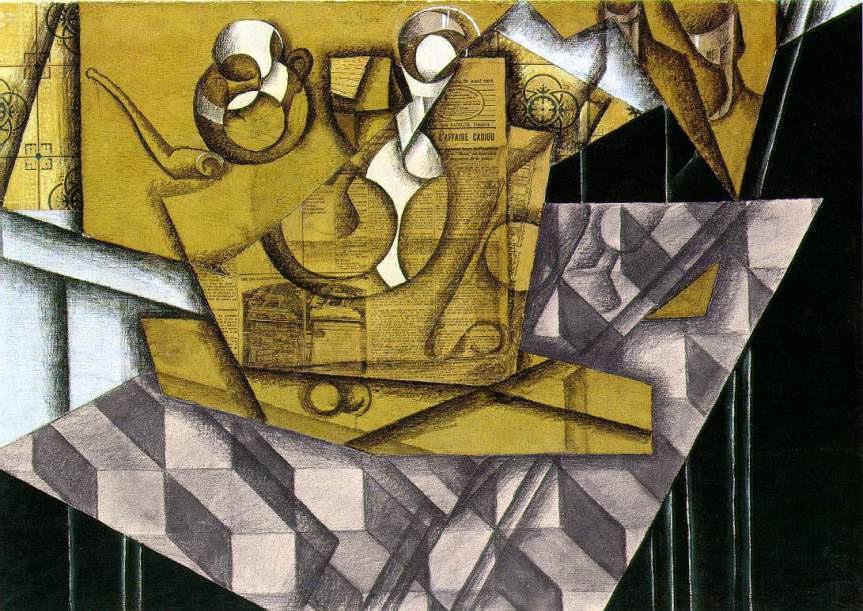Quando ci si avvicina al cibo ci si espone a una tentazione particolare, quella di pensarlo in astratto, di estrapolarlo dal suo contesto e degustarne quindi forma e sapore dandone per scontata l’esistenza, accettando con leggerezza una mitologia artificiosa spesso riconducibile unicamente a delle trovate pubblicitarie o a labili suggestioni di una tradizione tutta da verificare.
Si commette così l’errore di avvicinarsi al cibo con indifferenza. La stessa indifferenza che porta il consumatore a non curarsi della stagionalità dei prodotti e della sostenibilità delle colture e pretendere dunque di ritrovare in inverno le stesse zucchine che trovava in estate.
Una delle ragioni che animano questo blog è il tentativo di scorgere nel cibo tutta la complessità che lo caratterizza, ripensandolo in maniera non essenzialista. Si svela così una merce complessa, in grado di riflettere i più diversi aspetti sociali e culturali. Se si ricerca questo tipo di profondità, si noterà come il cibo si trasformi in potentissimo strumento di osservazione della realtà, una materia prima o un semi-lavorato dall’apparenza banale nella quale si annodano invece i fili di un discorso che è insieme reale e politico.
Rileggendo i processi di produzione di uno tra i più nobili e rinomati prodotti dell’industria casearia italiana, il Parmigiano Reggiano, finiscono per essere messi in discussione non solo molti dei luoghi comuni sul made in Italy e sulla tradizione gastronomica, ma anche una lunga serie di considerazioni politiche fondate su una difesa disinformata dei valori identitari e sui “pericoli” legati all’immigrazione.
Da tempo ormai la comunicazione pubblicitaria legata al Parmigiano Reggiano è fortemente orientata a trasmettere l’idea rassicurante di una secolare genealogia artigianale, di un sapere territoriale e tradizionale. “Dietro ogni scaglia di Parmigiano Reggiano ci sono quasi mille anni di storia e di gesti ripetuti”, questo raccontano le operose mani (dalla perfetta manicure) del nonno, padre di famiglia, artificiosamente artigiano che tramanda usi e costumi della degustazione del Parmigiano alla giovane nipote (“mi ha detto che lo fanno a mano, ogni mattina”).
Non si avvertono rotture, il Parmigiano “è unico”, ed è sempre quello, lo stesso che citava Boccaccio nel Decameron:
“in una contrada che si chiamava Bengodi, nella quale si legano le vigne con le salsicce e avevasi un’oca a denaio e un papero giunta; e eravi una montagna tutta di formaggio parmigiano grattugiato, sopra la quale stavan le genti che niuna altra cosa facevano che far maccheroni e raviuoli e cuocergli in brodo di capponi, e poi gli gittavan quindi giù, e chi più ne pigliava, più se n’aveva” (Boccaccio, Decameron, Giornata VIII, novella 3, 9).
Lo stesso dei medievali monaci benedettini di San Giovanni e di San Prospero o dei monaci cistercensi di San Martino di Valserena e Fontevivo. E ancora lo stesso dei sogni di fortuna del Giannettino, di Collodi, “Se vinco un terno – diceva agli amici – voglio comperare una villa, un palazzo, quattro cavalli scappatori, una bella galleria di quadri e una forma intera di cacio parmigiano” (Carlo Collodi, Giannettino, Milano, Barion, 1926).
Sarebbe questa stessa manualità, questo continuum nella tradizione, a riprodurre oggi il “Re dei formaggi” e a garantirne l’unicità, a riportalo quotidianamente nei supermercati, ad intagliarlo “a scaglie” nei buffet dei nostri aperitivi, pronto per essere degustato. Semplice e lineare.
O forse no. Forse sono anche altre le condizioni di (r)esistenza del Parmigiano Reggiano nel 2014, forse i valori di continuità, tradizione, artigianalità e unicità non bastano a portare a compimento il ciclo della produzione del Parmigiano, che, questa sì, permette agli allevatori e alle aziende del territorio di sopravvivere o di produrre utili. E come hanno, tra i primi, rilevato gli studenti della web tv Cortocircuito di Reggio Emilia, sono condizioni che ci interrogano sull’Italia di oggi, sulle evoluzioni della società contemporanea.
Immaginate di guidare lungo la strada provinciale 42 che collega Guastalla a Carpi. Facendo attenzione a mantener dritta la guida e sperando di non trovare il “nebbione” vedreste sfilare intorno a voi diversi caseifici; se decideste di fermarvi in uno dei numerosi spacci adiacenti vi potrebbe capitare con una buone probabilità di essere serviti non da Cesira o Iolanda ma da Rameshwari o da Shaila e sentireste forse una declinazione particolare di quella erre arrotata del parlato reggiano. Superato il primo momento di straniamento potreste a questo punto soprassedere, pagare uscire e proseguire oltre, arrivare a Carpi e riconnettervi con l’autostrada, continuare il vostro viaggio e al ritorno decantare agli amici le qualità di quel parmigiano preso là dove lo fanno accennando, magari con ironia, a quell’incontro inaspettato. Se invece decideste di sostare nel borgo agricolo di Novellara, il paese di Augusto Daolio, che sta proprio nel mezzo della provinciale 42, non tardereste poi molto a darvi spiegazione di quell’incontro. Tra i capannoni della zona industriale di Novellara sorge infatti il Gurdwara Singh Sabha, il maggiore tempio sikh d’Europa dopo quello di Londra.
L’Emilia-Romagna è la seconda regione italiana per presenza di cittadini indiani residenti dopo la Lombardia. La loro presenza si concentra nelle provincie di Reggio Emlia, Parma, Modena e Piacenza. A Novellara gli indiani arrivarono verso la fine degli anni Ottanta, molti di loro provenivano dal Punjab, la regione indiana dove il sikhismo è più praticato, e la loro comunità conta oggi circa 25mila persone.
Il Dossier immigrazione 2012 della Caritas ha stimato che il numero complessivo degli immigrati regolari abbia di poco superato i 5 milioni di persone alla fine del 2011. Gli immigrati dall’Asia, che alla fine del 2010 hanno inciso per il 12,7% sull’insieme dei residenti stranieri nell’Unione Europea, nell’anno successivo sono arrivati ad incidere in Italia per 6 punti percentuali in più, per un totale di 924.443 soggiornanti. In particolare, l’Italia è lo Stato membro che nell’UE accoglie le collettività più numerose di cinesi (277.570 soggiornanti nel 2011), filippini (152.382), bangladesi (106.671) e srilankesi (94. 577), mentre è il secondo Stato per quanto riguarda la presenza di indiani (145.164) e pakistani (90.185).
L’esistenza del Parmigiano Reggiano nel 2014 si lega inesorabilmente alla loro presenza e al loro lavoro. Un articolo apparso su TM News nell’ottobre del 2011 racconta ad esempio la storia di Manijt Singh. “arrivato in Italia da sette anni, lavora nella Formaggeria Cacciali. Il lavoro è duro, si inizia alle 6 del mattino e si termina alle 20 con una pausa di qualche ora, per produrre 10 forme al giorno. Graziano Cacciali fa il Parmigiano da quando aveva 12 anni: è stato lui a insegnare il mestiere a Manijt. La pazienza e la calma dei Sikh, insieme al rispetto delle vacche, ne fanno i lavoratori ideali per produrre il formaggio: in questa cooperativa, che conta oltre 1.100 capi di bestiame, sono la metà dei lavoratori. Un contributo fondamentale alla produzione di 3 milioni di forme di Parmigiano all’anno, per un mestiere che rischiava di scomparire, come spiega Stefano Gazzini”. Qui il video:
Ripensando a quell’immagine un po’ stantia di Parmigiano tradizionale, artigianale e familiare che ci viene quotidianamente riproposta, non si potranno non notare ora le pesanti contraddizioni che la attraversano. Se il Parmigiano Reggiano continua ad esistere è infatti, almeno in parte, merito dei Sikh di Novellara e del lavoro dei migranti, che attraverso la loro professionalità hanno saputo incontrare la domanda di manodopera sul territorio emiliano per il quale rappresentano una ricchezza sia in termini economici (il bilancio costi/benefici dell’immigrazione per le casse statali registra un +1,7 miliardi di euro) sia in termini culturali, garantendo la sopravvivenza di un prodotto tradizionale che rischiava altrimenti di scomparire. Una ricchezza che sarebbe giusto sottolineare, un bagaglio di conoscenze reali, pratiche e umane che vanno a sommarsi a quelle tradizionali e non certo ad annacquarle. A discapito del titolo dell’ultima campagna pubblicitaria legata al Parmigiano, intitolata “sono le differenze a renderlo unico”, rileviamo come le “differenze” vengano invece quotidianamente occultate e venga negato ogni riconoscimento all’indispensabile lavoro della manodopera migrante, a favore di un’immagine irreale, anacronistica e fintamente rassicurante made in Italy.