In un suo recente saggio (Cooked: A Natural History of Transformation, Penguin 2013), il giornalista americano Michael Pollan, già autore di diverse pubblicazioni sul comportamento alimentare e noto per le sue critiche all’industria agroalimentare (nonché per le sue posizioni ambigue su OGM e vegetarianismo), si concentra su quella che nel sottotitolo del libro definisce “una storia naturale della trasformazione”, ossia sull’aspetto materiale di quella collezione di processi che definiscono l’attività del cucinare e che, per dirla con l’autore, “mediano tra natura e cultura”, ossia trasformano attraverso l’elaborazione umana la materia prima naturale in un più o meno sofisticato prodotto culturale. Un tema complesso e di indubbio interesse antropologico, già affrontato da Lévi-Strauss nelle sue Mythologiques e in particolare ne Il cotto e il crudo, dove la trasformazione della materia prima in cibo cotto viene analizzata nel suo valore “culturale” che permette all’uomo, attraverso il passaggio cruciale del dominio sull’uso del fuoco, di divenire un essere socializzato, capace di mediazione e di adottare regole sociali. La cucina diventa così un campo di studio per l’analisi delle strutture sociali.
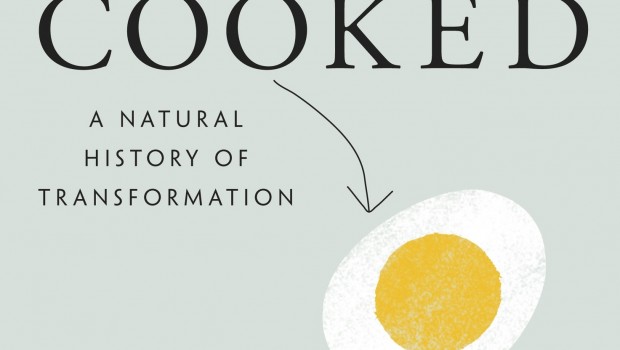
Vi è però, in questo ambito, almeno un aspetto che vale la pena di considerare separatamente. Nella prefazione al libro, Pollan ricorda come la sua indagine sui processi fondamentali di cottura del cibo lo abbia portato a indagare su quello che definisce il “paradosso culinario”: mentre da una parte le statistiche dimostrano chiaramente che la nostra civiltà spende sempre meno tempo nel cucinare (guidati in questa tendenza, senza grande sorpresa, dagli Stati Uniti), dall’altra parte si spende sempre più tempo a parlarne, a leggerne, a guardare show televisivi a tema e ad affollare i ristoranti con cucine a vista, nuovo status symbol della ristorazione.

Questa doppia tendenza comporta un aumento della domanda di prodotti alimentari che non richiedano grossi investimenti in termini di tempo nella loro preparazione finale, il che si traduce essenzialmente in un aumento del consumo di cibo industriale, che permette di esternalizzare alle piccole e grandi industrie il lavoro impiegato nella preparazione del pasto. Oltre alle conseguenze negative sulla nostra salute che ben conosciamo, questa tendenza ha effetti anche sull’istituzione del pasto e della sua preparazione. Perché, se prendiamo per buono Lévi-Strauss e consideriamo il cucinare come un processo essenziale di civilizzazione e socializzazione, ciò è nondimeno vero anche per quanto riguarda il consumo del pasto condiviso, per eccellenza occasione di conversazione e di condivisione. È per questo, fa notare Pollan, che la tipica tavola americana con i suoi cibi confezionati – e la conseguente soppressione della convivialità del pasto – incarna perfettamente quelle che definisce come “contraddizioni culturali del capitalismo”, ossia la tendenza di quest’ultimo a distruggere le forme sociali (la famiglia, in primis, ma anche la discussione “democratica” come valore fondante) su cui esso stesso si basa.

Volendo scavare più a fondo, queste contraddizioni “culturali” ne rispecchiano altre più fondamentali. L’industrializzazione della produzione alimentare, ad esempio, inserisce l’attività culinaria in un processo produttivo inevitabilmente strutturato a catena e internamente organizzato secondo quel processo di divisione del lavoro che costituisce la spina dorsale del nostro sistema economico. Come riassunto nel fin troppo noto esempio dello spillo di Adam Smith, risulterebbe impossibile a una manifattura produrre ricchezza se lo stesso individuo dovesse estrarre il ferro dalla miniera per ricavarne il filo metallico necessario alla produzione di spilli. Così, il tempo sottratto alla preparazione di un pasto può essere agevolmente impiegato in altre attività produttive, dall’elaborazione di teorie economiche alla stesura di articoli per un blog, aumentando contestualmente la produttività sociale. E tuttavia è evidente, senza bisogno di scomodare Marx, come a questa supposta liberazione delle capacità produttive facciano da contraltare altrettante contraddizioni. Come ricorda Pollan, allo stesso modo in cui i limpidi e luminosi schermi su cui leggiamo e scriviamo sono in realtà prodotti grazie a inquinantissime centrali a carbone, i frutti rossi contenuti nei cereali della nostra colazione possono finire nella confezione e quindi nella nostra credenza solo grazie alle giornate passate con la schiena piegata da schiere di lavoratori agricoli.

Anche la divisione del lavoro culinario, vale a dire, nasconde il suo lato oscuro. Si potrebbe anzi aggiungere che è la stessa divisione del lavoro che frappone quella barriera cognitiva che permette a noi fruitori finali del prodotto di poter ignorare le dinamiche reali in atto nel processo produttivo. Con conseguenze esiziali sul modo stesso in cui ci rapportiamo a quei prodotti, che ci appaiono sempre più reificati e sempre meno come il risultato dell’interazione umana con elementi naturali. Macellare personalmente una spalla di maiale, scrive Pollan, significa necessariamente essere messi di fronte al fatto che si sta macellando un grosso mammifero fatto di fasci di muscoli il cui scopo non è quello di nutrire noi. Difficile negare che questa esperienza, normalmente rimpiazzata dall’acquisto di un asettico taglio di carne in una vaschetta plastificata al supermercato, possa cambiare in maniera sostanziale il nostro modo di vedere il pranzo domenicale. Non è un caso che questo argomento sia uno dei più forti e uno dei più ricorrenti nelle battaglie antispeciste, poiché, per dirla con Ralph Waldo Emerson, “hai appena cenato, e per quanto il mattatoio sia scrupolosamente celato alla vista dalla grazia della lontananza, la complicità rimane”.

Ma nella “fine dell’attività culinaria” giace anche un’altra contraddizione, legata agli aspetti più patriarcali del nostro ordinamento sociale. L’esternalizzazione della produzione alimentare sembra infatti aver portato un avanzamento in termini di civiltà nella misura in cui le donne possono uscire dalle cucine in cui sono state relegate per secoli dal loro ruolo di “angelo del focolare” con l’unico sostanziale compito di gestire l’ambiente domestico e sfamare la famiglia, ruolo che oggi sembra apparire sorprendentemente inattuale. Se le cose stanno davvero così, verrebbe allora da chiedersi per quale ragione questa divisione sessuale del lavoro abbia potuto essere imposta per secoli. Secondo la scienziata politica femminista Janet A. Flemming, ad esempio, una delle ragioni è da ricercarsi nella radici squisitamente materiali e sensoriali dell’attività culinaria: la manipolazione del cibo riguarda essenzialmente l’uso del tatto, dell’olfatto e del gusto, tradizionalmente considerati meno nobili della vista e dell’udito, associati alla dimensione della contemplazione. Così, in buona parte della tradizione filosofica, religiosa e letteraria il cibo è stato associato alla sfera corporale, ferina e istintuale, caratteristiche che in una cultura sessista vengono generalmente attribuite all’universo femminile. Ma se questa divisione sessuale del lavoro è stata davvero superata, perché ci appare ancora oggi a dir poco inappropriata quella campagna pubblicitaria lanciata negli anni ’70 da KFC, dove un manifesto pubblicitario che raffigurava il caratteristico secchiello di pollo fritto era accompagnato dalla scritta “La liberazione della donna”? Non solo, verrebbe da dire, per la discutibile associazione tra il non cucinare (anzi, tra il consumare polli da batteria acquistati da una delle catene di fast food più criticate al mondo) e la pretesa di una qualche forma di avanzamento sociale. E nemmeno per il fatto che una parte essenziale della sfera privata quale è il pasto viene in questo modo subappaltata a una multinazionale del take away. Ciò che vi è in profondità è un paradosso ancora più inquietante: come i dati mostrano, una gran parte delle donne che oggi sono uscite dalle cucine di casa per entrare nel mondo del lavoro sono in realtà impiegate nella produzione alimentare, cucinando per le altre famiglie nel tempo sottratto a cucinare per la propria. Sembrerebbe che il supposto superamento dei ruoli di genere sia tutt’altro che un dato di fatto. D’altro canto, le pubblicità di prodotti alimentari si rivolgono ancora oggi quasi esclusivamente alle donne, segno che neppure la cultura sfacciatamente sessista che quella divisione di ruoli ha mantenuto può essere data per superata.

Per Pollan, coerentemente con lo spirito del libro, queste contraddizioni parlano a favore dell’urgenza e dell’importanza della riappropriazione dell’attività culinaria sottraendola alla produzione industriale del cibo. Un fatto è certo: se le pratiche culturali riflettono delle contraddizioni sociali profonde e radicate, la cucina non sembra fare eccezione.
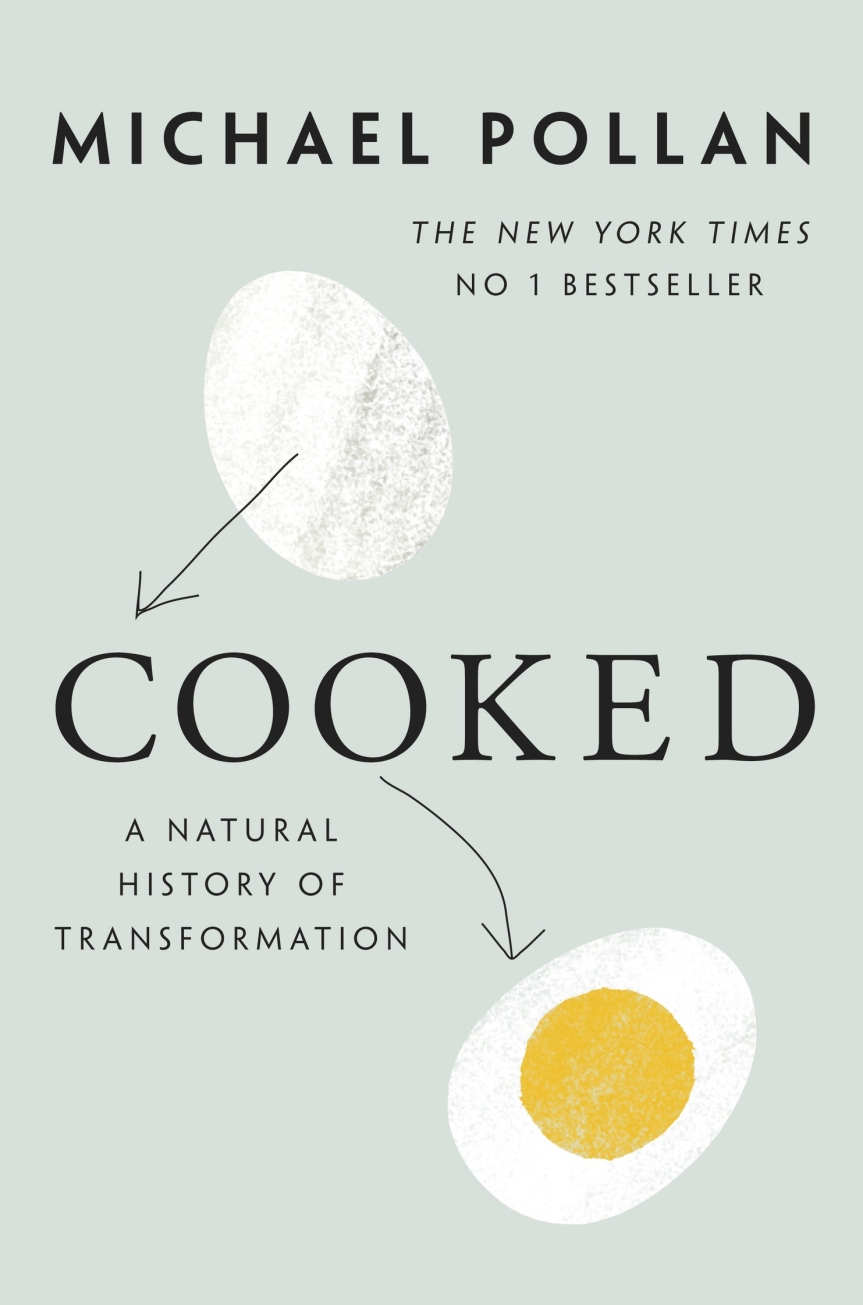
Un pensiero riguardo “Cucina: storia naturale di una contraddizione”