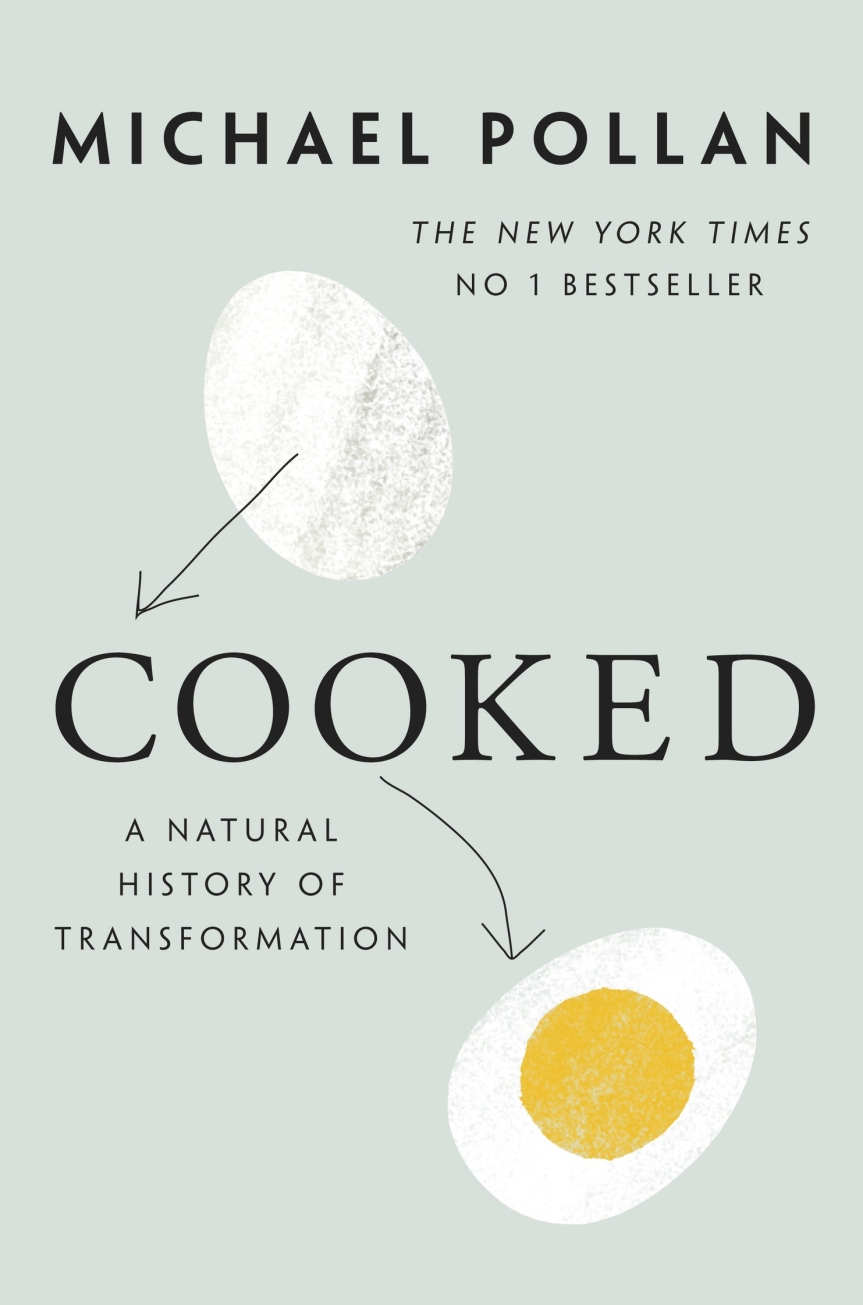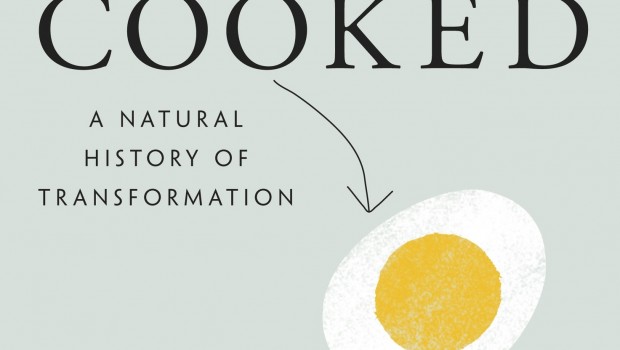Incontriamo Loris Tonino Paroli nel ristorante da Gianni, a un tavolo dell’ampia sala da pranzo vicino al camino acceso in maiolica verde. Sulla parete opposta, il poster di una mostra di dipinti ad olio dello stesso Loris, le cui giornate oscillano oggi “tra l’orto e l’arte”, come ama ricordare, ma che per sedici lunghi anni si sono svolte nelle patrie galere dove scontava la sua militanza nelle Brigate Rosse. Militanza conclusasi nel 1975, quando venne arrestato e incriminato per costituzione di banda armata, associazione sovversiva e per aver partecipato alla liberazione di Renato Curcio in un assalto al carcere di Casale Monferrato guidato da Mara Cagol, che verrà uccisa pochi mesi dopo a seguito di uno scontro a fuoco con i carabinieri.
La sala principale è illuminata quasi esclusivamente dalla luce del sole pomeridiano che filtra dalla veranda, da dove ogni tanto si sente un gallo cantare dal pollaio retrostante. Paroli spiega che una credenza dei contadini locali vuole che il canto del gallo fuori orario sia presagio del tempo che sta per cambiare. Siamo a Paullo, località di Costaferrata, a 650 metri sul livello del mare e appena sopra la strada provinciale che da Reggio Emilia conduce all’Appennino. È qui che nel 1964 Gianni Incerti aprì il ristorante che porta il suo nome e che ancora oggi è gestito dalla moglie Anna e dai due figli Elvio e Robby. È proprio la signora Anna ad accoglierci spiegando premurosa che le luci interne della sala sono tenute volutamente basse per tenere le mosche lontane dal prosciutto che accompagna lo gnocco fritto.
Anna Incerti e Loris Paroli sono cugini. Anzi, come tengono a precisare, “cugini due volte”, da parte di madre e da parte di padre, in un complesso rapporto di parentela che sa di storie familiari che si perdono indietro negli anni. Per un curioso accidente della storia, proprio questa consanguineità è alla base di quello che divenne noto come “convegno di Pecorile”, l’atto di battesimo delle Brigate Rosse. Il borgo di Pecorile si trova in realtà diversi chilometri più sopra, ma negli anni sessanta era l’unico segnalato da un cartello stradale e così venne identificato retrospettivamente come il luogo di nascita della lotta armata in Italia: una delle tante e in fondo la minore delle inesattezze storiche che punteggiano le ricostruzioni della storia delle BR. A dare i natali all’organizzazione parrebbe invece essere stata proprio Costaferrata, e in particolare la sala del ristorante da Gianni.
Siamo nell’estate del 1970, appena dopo l’autunno caldo del ’69 e un inverno reso ancora più rovente dal tritolo detonato a Piazza Fontana. A seguito di quegli eventi e con l’esperienza dei gruppi extraparlamentari destinata a una svolta, i militanti che allora si raccoglievano dietro la sigla Sinistra Proletaria si trovarono di fronte alla necessità di riunirsi per discutere la propria strategia politica per il futuro. La scelta del luogo del convegno cadde sul ristorante da Gianni, ma per ragioni esclusivamente logistiche, spiega Paroli. Reggio Emilia poteva servire da punto intermedio tra il Nord Italia e Roma e, longitudinalmente, era pressoché equidistante tra i compagni genovesi, i Collettivi Politici Metropolitani di Milano e Torino e il gruppo di Renato Curcio e Mara Cagol proveniente dalla Facoltà di Sociologia di Trento. Proprio a Reggio, d’altronde, in un pied-à-terre sulla principale via Emilia aveva base il gruppo detto appunto “dell’appartamento”, di cui facevano parte i futuri brigatisti Prospero Gallinari, Alberto Franceschini e lo stesso Paroli. Fu quest’ultimo, nel luglio del 1970, a suggerire la locanda della cugina come luogo di riunione per accogliere le decine di giovani extraparlamentari radunatesi nel reggiano.
Oggi, nei locali del piano superiore della locanda non alloggiano più clienti ma i salami in stagionatura che vengono serviti con l’antipasto insieme al pecorino dell’Appennino. Ma anche in quei giorni ormai lontani il quasi centinaio di militanti convenuti dovette cercare ricovero presso le abitazioni locali per trovare ospitalità per la notte. Durante le discussioni diurne nella sala da pranzo del ristorante, invece, si delinearono secondo Paroli tre linee politiche che avrebbero contrassegnato l’estrema sinistra italiana negli anni successivi: chi si spostò verso l’area dell’autonomia, chi abbracciò la “superclandestinità”, e chi appoggiò invece la linea della “propaganda armata” e dell’“attività politico-militare”, sancendo di fatto la nascita delle BR.
La scelta della lotta armata e della clandestinità sarebbe maturata solo successivamente, come pure la sigla “Brigate Rosse” che alcuni attribuiscono a Mara Cagol, la quale avrebbe mutuato il nome della Rote Armee Fraktion tedesca, adattando l’impegnativo “Frazione Armata Rossa” nel più confacente “Brigata Rossa”. Altri, come Alberto Franceschini, fanno però nascere il celebre simbolo della stella cerchiata proprio sui tavoli del ristorante da Gianni. L’ispirazione sarebbe venuta dalla stella a cinque punte dei Tupamaros che in quegli stessi anni praticavano la propaganda armata in Uruguay; riprodotta a mano, la stella ne uscì deformata, con le due punte inferiori allungate, e qualcun altro ebbe l’idea di cerchiarla usando una moneta da 100 lire. La leggenda vuole anzi che le prime prove siano state incise a lama sulle panche dell’osteria, e che lì sarebbero rimaste per richiesta della questura se il signor Gianni, il titolare, estraneo alle vicende delle BR, non le avesse pragmaticamente utilizzate per compiere dei lavori di ristrutturazione.
Vincenzo Tessandori della Stampa una volta ha provato a ricostruire in cosa consistesse il pranzo di quei pochi giorni d’estate del 1970, con l’aiuto di un Paroli fresco della libertà appena riguadagnata. Salame nostrano e salsicce, prosciutto crudo e ciccioli come antipasto, aperto dal coro di Bella ciao. Seguirono i cappelletti in brodo e i tortelli di bietole, ma anche lasagne e cannelloni. E ancora arrosti misti, coniglio, faraona e agnello accompagnati da patate e insalata. Tutto per la modica cifra di quattromila lire. Un menu a dir poco corposo, che poteva servire a ristorare dopo estenuanti discussioni politiche ed escursioni preappenniniche, ma che con poche variazioni somiglia alla cucina tradizionale che da Gianni ripropone ancora oggi.
Quando Loris Tonino Paroli ci raggiunge al tavolo, abbiamo già abbondantemente consumato erbazzone e polenta fritta, oltre a una generosa porzione di tortelli con quattro ripieni diversi che Elvio ci ha servito in tavola direttamente con la padella, ma la signora Anna ci sta ancora chiedendo premurosa “cosa mangiamo volentieri”. Paroli si unisce in tempo per un brindisi con un bicchiere di lambrusco, prima del caffè che decidiamo di bere direttamente al bancone dietro cui si fronteggiano il ritratto del Che e quello di Marilyn. Di fronte, un tavolino su cui sono dispiegate l’edizione del giorno del Manifesto, della nuova Unità renziana, e la pagina sportiva della Gazzetta di Reggio. Anni fa c’era anche un ritratto giovanile della signora Anna, che il figlio Elvio giura assomigliasse in modo impressionante ad Anna Magnani, ma la diretta interessata lo fece rimuovere per riservatezza di fronte alla curiosità degli avventori. Immagini che sintetizzano bene l’atmosfera genuina del locale. Anche in quell’estate del 1970 nessuno poteva essere a conoscenza del futuro dispiegarsi degli eventi storici, né i diretti interessati, né tantomeno i coniugi Incerti che gestivano la trattoria, e neppure i carabinieri del posto, che dopo un controllo di routine non trovarono motivi per proseguire con ulteriori indagini.
D’altronde, voler forzare l’intera matrice politico-culturale delle Brigate Rosse nelle maglie esclusive di un contesto rurale fatto di tradizioni contadine e gloriose appartenenze politiche significa perderne tutta la complessità, fatta anche e soprattutto di fabbrica, metropoli e lotte operaie. Non solo i compagni della Pirelli, della Sit-Siemens, dell’Alfa, della Marelli e dell’IBM di Milano; anche Franceschini e lo stesso Paroli avevano conosciuto il padronato industriale reggiano, alle Officine Meccaniche Reggiane il primo, come tecnico rettificatore alla Lombardini Motori il secondo. Operaio alle Reggiane, del resto, era stato anche il padre di Anna, scendendo in bici fino ai cancelli dello stabilimento per fare ritorno in altura a fine turno. Persino Prospero Gallinari, che a lavorare nei campi ci era andato all’età di dodici anni, ha intitolato la sua autobiografia Un contadino nella metropoli, a sottolineare come l’esperienza armata sia stata legata alle lotte nel capitalismo avanzato più che a nostalgie resistenziali.
Dopo pranzo, Loris ci conduce in una passeggiata in quella che definisce con una punta di orgoglio il “suo” monte, un appezzamento sui calanchi appena sopra la provinciale ricevuto in eredità da uno zio. Di lì, tra il rosmarino e le sculture che il proprietario vi ha installato negli anni, si domina la vallata sottostante e il prospiciente castello dell’imperatrice Matilde di Canossa, memoria di fasti antichi quando, quasi mille anni prima del “convegno di Pecorile”, la zona era stata al centro delle vicende politiche di mezza Europa.
È qui che tornano in mente le divagazioni immaginifiche di Robby, il figlio minore di Gianni e Anna, che si definisce “pellerossa nell’anima” e che difatti porta i capelli coerentemente legati in due trecce alla maniera dei navajo. Nell’accoglierci all’ingresso da Gianni, ci parla del torrente Crostolo che scorre sotto Costaferrata e della simbologia dell’acqua generatrice di vita, ma anche della “pietra magica” di Bismantova, piccola vetta del vicino Appennino e luogo di culto già dal neolitico.
È lui ad offrirci involontariamente una suggestiva chiave di lettura complessiva della vicenda, prima di ritirarsi per riportare all’ordine una nidiata di recalcitranti gattini appena nati: “la gente di qua ama nascondersi”, sentenzia alludendo ai dualismi che da sempre accompagnano la storia politica locale. Poco più su, racconta, ad Albinea, aveva sede il comando tedesco preposto al controllo della Linea Gotica, ma nella stessa area operavano anche la 26a e la 145a Brigata Garibaldi, che sotto il comando alleato sferrarono un pesante attacco ai nazisti nella primavera del ’45. L’anno precedente, nella notte di San Giovanni, altri tre partigiani della 26a erano caduti in uno scontro a fuoco con i tedeschi in seguito a un attentato fallito. La rappresaglia tedesca si abbatté a colpi di mitra sugli ospiti della vicina locanda, che venne data alle fiamme in quello che sarà ricordato come l’“eccidio di Bettola”. Era solo la prima osteria del posto destinata a diventare teatro della Storia.






 Your most recent book, Jerusalem, is dense with digressions on the cultural background of recipes. How can a closer understanding of the cultural and social roots of food affect or even change our approach to it?
Your most recent book, Jerusalem, is dense with digressions on the cultural background of recipes. How can a closer understanding of the cultural and social roots of food affect or even change our approach to it?
 Il suo ultimo libro, Jerusalem, è denso di digressioni sul retroterra culturale delle ricette. In che modo una maggiore comprensione delle radici sociali e culturali del cibo può modificare il nostro approccio a esso?
Il suo ultimo libro, Jerusalem, è denso di digressioni sul retroterra culturale delle ricette. In che modo una maggiore comprensione delle radici sociali e culturali del cibo può modificare il nostro approccio a esso?