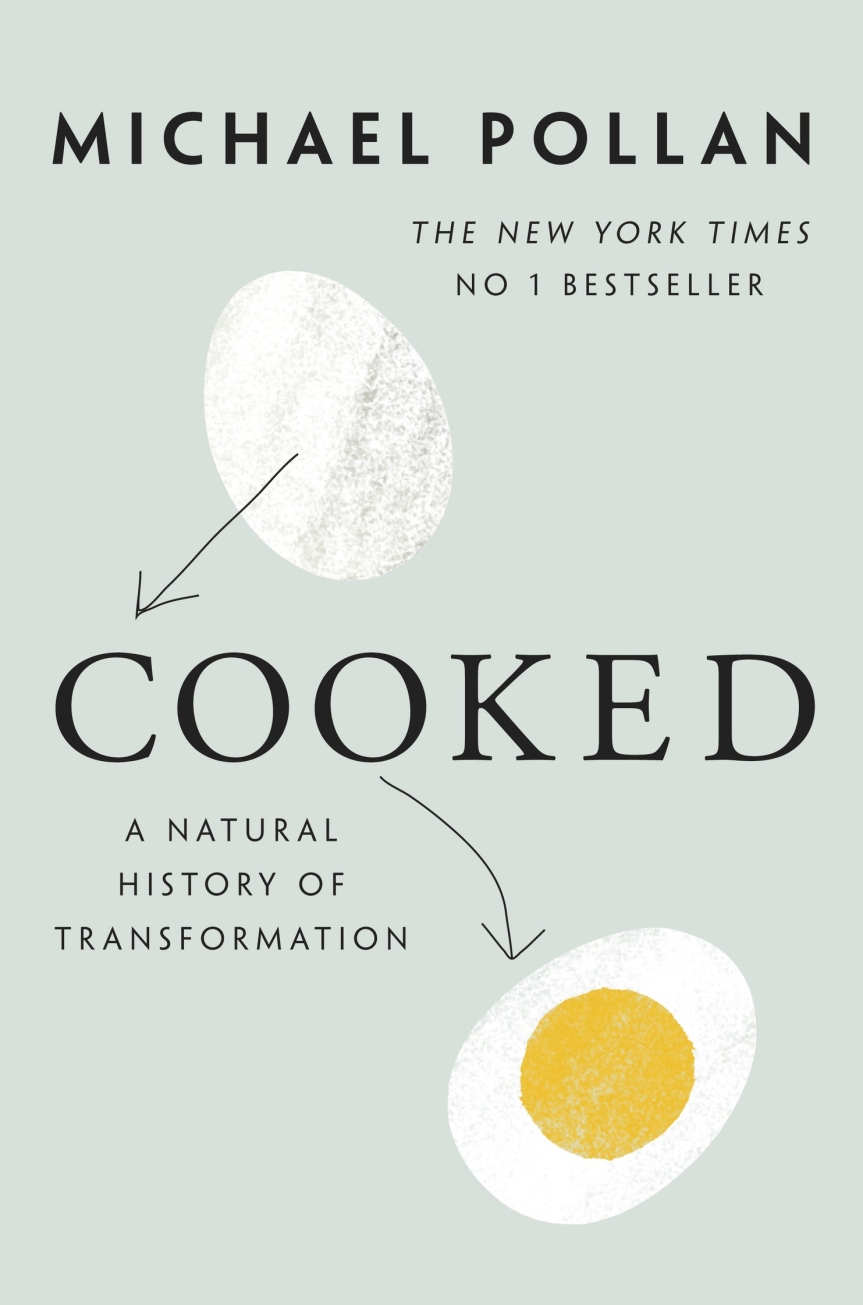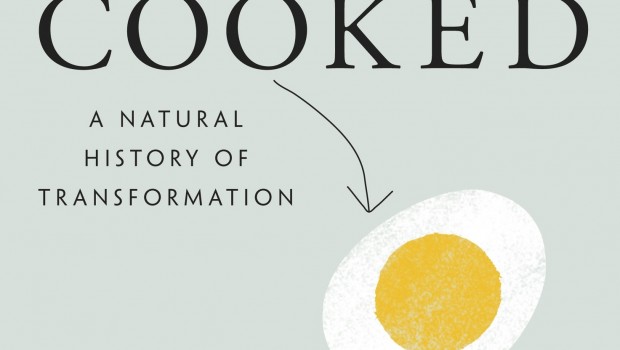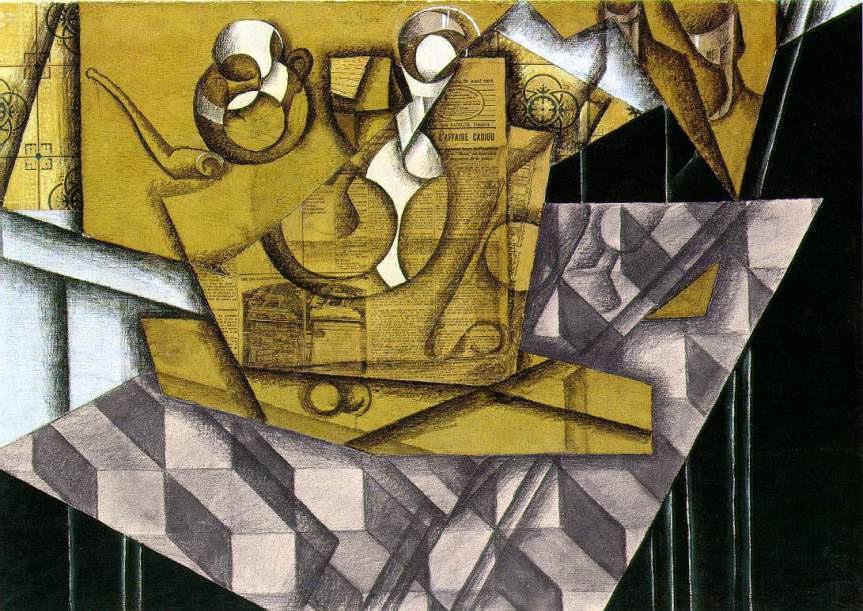La misconosciuta figura della monaca e poetessa messicana Suor Juana Inés de la Cruz (1648 – 1695) continua, a dispetto della sua scarsa notorietà, ad affascinare ancora tre secoli dopo la sua morte. Nel 1980 il Premio Nobel per la letteratura Octavio Paz le ha dedicato il saggio Suor Juana Inés de la Cruz o le insidie della fede, da cui dieci anni dopo è stato tratto il film argentino Yo, la peor de todas con Assumpta Serna e Dominique Sanda, mentre in Italia Dacia Maraini le ha dedicato il testo teatrale Suor Juana, la casa del linguaggio. Proprio nel suo libro, Octavio Paz commentava:
Da oltre cinquant’anni la sua vita e la sua opera continuano a incuriosire e ad appassionare eruditi, critici e semplici lettori: perché, giovane e bella, ha scelto la vita monacale? Quale fu la vera indole delle sue tendenze affettive ed erotiche? Qual è il senso e la collocazione di Primero sueño nella storia della poesia? Come furono i suoi rapporti con la gerarchia ecclesiastica? Perché rinunciò alla passione della sua vita, le lettere e il sapere? Fu una rinuncia dovuta a conversione o un’abdicazione? (Octavio Paz, Suor Juana Inés de la Cruz o le insidie della fede, Garzanti, p. 25)
Interrogativi che muovono evidentemente dall’affascinante biografia di Suor Juana. Figlia illegittima di padre nobile ma di madre creola, fu allevata dalla famiglia materna, imparando dalla sorella maggiore a leggere e a scrivere prima ancora di compiere tre anni. Progettando a sette anni di travestirsi da ragazzo per poter frequentare l’università a Città del Messico, riuscì pochi anni dopo a giungere nella capitale entrando nella corte della viceregina come damigella d’onore. Pur senza essere animata da particolare fervore religioso e spinta piuttosto dal desiderio di dedicarsi interamente ai libri, prese i voti monacali entrando poi nel convento di San Girolamo, dove rimase per il resto della sua vita. Come scriverà lei stessa:
Presi i voti perché, pur sapendo che lo stato monacale presentava aspetti (di quelli marginali, parlo, non di quelli sostanziali) che non mi andavano a genio, era comunque, per il netto rifiuto che provavo del matrimonio, la cosa meno fuori luogo e più congrua che potessi scegliere per la mia salvazione; al quale progetto (come al fine più importante) cedettero e piegarono il capo tutti i miei capriccetti, ossia il desiderio di vivere sola, di non avere alcuna occupazione che intralciasse la libertà dei miei studi, né rumore di comunità che disturbasse il quieto silenzio dei miei libri. (Juana Inés de la Cruz, Risposta a Suor Filotea, Sellerio, p. 25)
Qui, dedicandosi interamente alle sue letture, insospettisce la superiora, che riteneva lo studio cosa da Inquisizione (siamo nel Messico coloniale della Spagna controriformista) e inadatto alla “santa ignoranza” che si addiceva a una monaca. Ma la notorietà letteraria Suor Juana comincia a raggiungerla qualche anno dopo, con l’arrivo nella Nuova Spagna del nuovo viceré e della di lui consorte, María Luisa Manrique. In questa occasione, a Suor Juana viene commissionata l’inscrizione da apporre sull’arco di trionfo che tradizionalmente veniva posto in accoglienza del nuovo governatore. Fu con questo incontro che tra María Luisa e Suor Juana ebbe inizio un rapporto di reciproca stima e affettuosa amicizia che, scrive ancora Octavio Paz, “si trasformò rapidamente in un sentimento tanto appassionato che può solo essere chiamato amore.” (Suor Juana Inés de la Cruz o le insidie della fede, p. 258)
Fu proprio grazie alla protezione di María Luisa Manrique che i versi composti da quella che verrà chiamata “la Fenice d’America” assunsero fama crescente fino alla pubblicazione nella madrepatria spagnola dell’opera Inundación Castálida, che divenne uno dei primi casi di letteratura latinoamericana ad acquisire notorietà internazionale. Naturalmente, la popolarità di Suor Juana finì per attirarle l’avversione delle gerarchie ecclesiastiche, in primo luogo l’arcivescovo di Città del Messico, tramandatoci come figura austera e misogina, abituato “a portare il cilicio, a fustigarsi due volte alla settimana e a cambiarsi gli abiti così raramente che il suo corpo era infestato dalle cimici” e solito affermare che “qualora una donna fosse entrata in casa sua, avrebbe fatto svellere le mattonelle da lei calpestate.” (Angelo Morino, Il libro di cucina di Juana Inés de la Cruz, Sellerio, p. 22)
È in questo contesto che il vescovo di Puebla don Manuel Fernández de Santa Cruz, antica conoscenza di Suor Juana, fu spinto a scrivere dietro lo pseudonimo di Suor Filotea un opuscolo polemico cui anteponeva una pubblica reprimenda nei confronti della religiosa, ammonendola ad abbandonare le lettere profane per dedicarsi esclusivamente a quelle religiose. La Risposta a Suor Filotea che Juana Inés de la Cruz pubblicò l’anno successivo sarebbe divenuta uno dei testi più celebri della religiosa e costituisce un’appassionata difesa del diritto all’accesso alla cultura da parte del sesso femminile, rivendicata ricordando precedenti nobili che andavano dalla regina di Saba, “dotta sì da osar tentare con enigmi la saggezza del savio tra i savî”, e dalle sibille “elette da Dio per profetizzare i più insigni misteri della nostra Fede”, a Nicostrata “inventrice delle lettere latine ed eruditissima in quelle greche” e Santa Caterina d’Alessandria “che insegnava e possedeva ogni saggezza dei savî d’Egitto” (Risposta a Suor Filotea, pp. 43-44).
Tra le numerose opere di Suor Juana figurano tuttavia anche diversi scritti minori, tra cui un breve Libro di cucina destinato presumibilmente alla circolazione interna al convento di San Girolamo piuttosto che alla pubblicazione. L’attribuzione di questo scritto alla religiosa è in realtà dubbia. Nonostante un sigillo ne certifichi la paternità (anzi, la maternità), la sciatteria formale del testo culinario e la materialità del suo contenuto stridono con lo stile barocco e l’alto registro dei suoi componimenti poetici e letterari. Inoltre, è noto che le suore del convento di San Girolamo disponevano di schiave per il disbrigo delle faccende domestiche, e che anche a Suor Juana ne fu donata una dalla madre (protagonista del testo teatrale della Maraini). Di certo, il carattere di Juana doveva portarla preferibilmente a indugiare sui libri piuttosto che tra i fornelli.
Rimane il fatto che le ricette raccolte nel Libro di cucina sono costituite prevalentemente da dolci – spesso a base di ingredienti esotici come lo zapote o la guanábana, o richiedenti le preparazioni lunghe e sofisticate tipiche delle cucine arcaiche – testimoni di un certo gusto barocco per la presentazione e più adatti alle occasioni mondane rappresentate dagli incontri letterari ricevuti da Suor Juana piuttosto che alla quotidianità frugale di un convento di monache. Nel libro figurano in effetti più versioni di un “dolce di noci” simile a quelli che Suor Juana aveva fatto pervenire alla Manrique come uno dei tanti omaggi scambiati tra le due, che di volta in volta potevano essere preziose piume di quetzal inviate da parte della viceregina o una rosa colta di prima mattina nel giardino del convento da parte della monaca.
Nel libro di cucina è però possibile leggere in filigrana una dimensione ancora più profonda della vita di Suor Juana. Proprio la cucina, infatti, diveniva nella Risposta a Suor Filotea il pretesto per rivendicare il diritto allo studio e all’insegnamento, e anzi rappresentava un compendio di cultura materiale che veniva inappropriatamente relegata alla vita pratica e che invece non poteva che rappresentare un valore aggiunto alla cultura delle lettere di proprietà maschile:
E che cosa non potrei raccontarvi, Signora, dei segreti naturali che ho scoperto mentre cucinavo? Vedo che un uovo si rapprende e frigge nel burro o nell’olio e, al contrario, si spezza nello sciroppo; vedo che, affinché lo zucchero si conservi fluido, basta aggiungervi una piccolissima parte d’acqua in cui sia stata messa una cotogna o un altro frutto aspro; vedo che il tuorlo e l’albume di uno stesso uovo sono così contrari, che per lo zucchero possono venire usati separatamente ma mai insieme. Non voglio comunque stancarvi con tali inezie, che riferisco solo per darvi intera notizia della mia natura, e, credo, vi faranno sorridere; ma, Signora, che cosa possiamo mai sapere noi donne se non filosofie da cucina? Aveva ragione Lupercio Leonardo, secondo cui si può benissimo filosofare e preparar la cena. E io dico spesso pensando a tali bagatelle: se Aristotele avesse cucinato, avrebbe scritto molto di più. (Risposta a Suor Filotea, p. 27)
La biografia intellettuale di Suor Juana termina tristemente sotto le pressioni clericali con una rinuncia alle lettere firmata col sangue e la svendita sottocosto della sua sterminata biblioteca a scopo benefico. Rimangono invece, insieme alle sue opere, l’intransigenza con cui difendeva il suo diritto alla cultura, sia materiale che spirituale, e la sua insofferenza verso l’autorità ecclesiastica che glielo negò.